Di societing e marchi
Se un tempo sedersi con qualcuno a tavola simboleggiava
accettazione e vicinanza, oggi gli impegni (la “vita di fretta” di Zygmunt
Bauman) hanno sovente polverizzato le convivialità domestiche e i valori del
cibo, e perciò aperto un varco ai prodotti più chimici, artificiali, manipolati,
an-identitari, global ma per nulla o ben poco glocal... Duole ammetterlo, e
suona paradossale, tanto più in Italia, ma non sarebbe mai potuto avvenire in
una società che davvero diffusamente custodisse nitide ideologie circa i propri
cibi e le tradizioni per ben avvicinarli. Per G. Richards e A. M. Hjalager, che
indagarono i nessi fra turismo e gastronomia già in un prezioso lavoro del
2002, a produrre la nuova consapevolezza del cibo quale manifestazione
dell’interiorità di un soggetto è stato, prevalentemente, proprio il montante
senso di precarietà individuale e collettiva in cui è affondato il consumatore
odierno, spaesato a causa dello sgretolamento (delle consuetudini, e delle
impalcature di significato radicatesi nei secoli) indotto dalle irrefrenate
derive della mondializzazione.
In particolare quindi, com’è stato scritto, “per ciò che
riguarda i nuovi approcci di marketing, la ricerca è sempre più orientata
all’esplorazione delle nuove frontiere del Societing, secondo la definizione che
ne danno Bernard Cova e Giampaolo Fabris. Bernard Cova evidenzia come sia in
atto un ripiegamento del modello individualista, che mette l’accento su un
ritorno al legame sociale nelle società occidentali e al desiderio di
partecipare a comunità diverse. Il Societing, declinato in chiave turistica,
cerca di contribuire al rafforzamento del vincolo sociale tra viaggiatore e
ospitante, ma anche tra i viaggiatori stessi, con la formazione ad esempio di
circoli/club di viaggiatori. In questa logica si tratta di conciliare lo
sviluppo del turismo con la tutela dell'ambiente ed il rispetto dell'identità
della storia e della cultura delle popolazioni locali e del loro territorio ma,
anche, di proporre nuovi mezzi e luoghi coniugati con modalità d’intervento che
preservano e non dilapidano le risorse locali, generando benefici economici,
sociali e culturali per tutta la comunità.
Si tratta ovviamente di questioni (e opportunità) cogenti,
che chiamano in causa l’amministratore, il cittadino, l’impresa, il manager turistico,
l’industria alimentare.
Chi scrive ha condotto in passato anche un’analisi dei
marchi e delle certificazioni ambientali (i più diffusi), e del loro “utilizzo”
anche come strumenti – diretti o indiretti - di marketing turistico. L’utilizzo
dei marchi nasce – come noto - per elevare, tramite sistemi procedurali, gli standard
di qualità delle destinazioni e delle imprese ospitali, e per “divulgare” i
risultati conseguiti, affinché il mainstreaming dissemini sensibilizzazione
presso i vari attori e destinatari in gioco. L’assegnazione/utilizzo dei marchi
è però sovente “afflitta” da alcuni limiti che ne attenuano i benefici. Prima
di tutto l’eccessiva proliferazione (si pensi all’esistenza d’oltre 50 marchi
solo in Europa), talora legata alla sbagliata concezione del marchio come mero
veicolo di immediati vantaggi economici – là dove l’ottica corretta è viceversa
quella dei risultati sul medio-lungo periodo - . Non solo, l’eccessiva
proliferazione ha come immediata conseguenza il disorientamento del turista,
che non riesce più a decifrare le vere differenze qualitative fra l’uno e gli
altri, e addirittura può tendere a dimenticarli tutti, senza veramente giungere
a distinzioni in termini di serietà e affidabilità (l’iniziativa comunitaria
“Visit”, anni fa, si è proprio prefissa di porre un po’ d’ordine nell’intricato
panorama). Al contempo, è necessario che i marchi siano pensati in modo tale da
rappresentare un numero significativo di imprese. Così come è possibile trovare
sui territori esempi di nutrita presenza di marchi, altrettanto possiamo
trovare marchi che non raggiungono una massa critica, o che “scolorano” col
passare del tempo. Infine, i costi d’istruttoria e di mantenimento non debbono
risultare troppo onerosi e scoraggianti per le imprese aderenti.
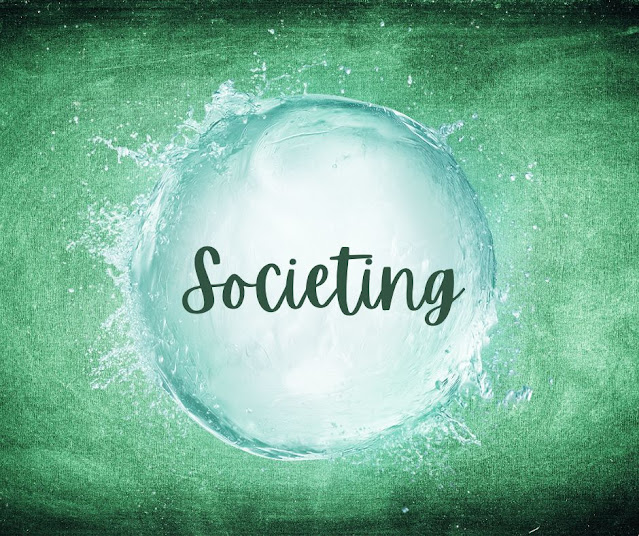


Commenti
Posta un commento